![]() La Canarina assassinata è uno dei più bei Gialli dell’Età d’Oro del romanzo poliziesco.
La Canarina assassinata è uno dei più bei Gialli dell’Età d’Oro del romanzo poliziesco.
Quando lo scrisse, Wilard Huntigdon Wright, aveva già pubblicato The Benson Murder Case, 1926 “La strana morte del Signor Benson”, romanzo che aveva ottenuto un buon successo. Ma è senza dubbio proprio con The Canary Murder Case, 1927 “La Canarina assassinata” e poi con The Greene Murder Case, 1928, “La Tragedia di Casa Greene”, che si impose come il più grande autore della sua epoca: due romanzi che fecero scuola.
Antitetici è bene dirlo: così come “La Tragedia di Casa Greene” è una vicenda di morte che si svolge claustrofobicamente in una dimora in cui sono costretti a vivere gli eredi di una fortuna, ed in cui aleggia dal primo all’ultimo istante un’atmosfera greve e plumbea, ne “La Canarina Assassinata”, l’atmosfera è invece frivola e salottiera, molto più leggera, ma al tempo stesso complicata.
I tre romanzi assieme formano una ideale trilogia
Da un certo punto di vista, si può dire, a mio parere, che sia uno dei più grandi romanzi polizieschi che siano mai stati concepiti. Oggi, che le soluzioni vandiniane sono state fatte proprie e poi superate da tanti grandi scrittori a lui successivi, Van Dine sembra essere Pollicino, e a taluni le sue soluzioni fanno ridere. Invece, non si può pensare alla letteratura poliziesca degli anni ’30, senza inchinarsi reverenzialmente dinanzi a Van Dine. Perché senza di lui non ci sarebbero stati Ellery Queen, Charles Daly King, il primo Rex Stout.
E dei romanzi di Van Dine, i due che hanno avuto più influsso sui posteri sono stati proprio The Canary Murder Case e The Greene Murder Case. In particolare The Canary Murder Case, ebbe un effetto dirompente all’epoca: fu in testa per parecchi mesi alle classifiche dei libri più letti.
Julian Symons nella sua opera critica più famosa, Bloody Murder, riportò il giudizio di un altro critico, Howard Haycraft, scrivendo che “ ..his second book, The Canary Murder Case 1927, broke all modern publishing records for detective fiction at the time” (Julian Symons, Bloody Murder, Penguin Books, 1985, pag.101).
Più in là a testimoniare il grandissimo successo riportato da questo romanzo e dal successivo romanzo, che sconvolsero la letteratura poliziesca del tempo, dominata dagli autori britannici, Symons affermava che “It was said that he had lifted the detective story on to the plane of a fine art, and by his own account he was the favorite crime writer of two Presidents” (op. cit. pag. 102).
Ma perché The Canary Murder Case ebbe tutto questo successo? Analizziamo la storia.
Innanzitutto chi è la Canarina? Prendendo a prestito la stessa prosa di Wilard Huntigdon Wright “..Margaret Odell aveva ricevuto il soprannome di Canarina in seguito a una parte sostenuta in un elaborato balletto ornitologico delle Folies, dove ogni ragazza aveva una gonna che richiamava qualche uccello. A lei era toccato il ruolo della canarina; e il suo costume di satin bianco e giallo, insieme alla massa di luminosi capelli biondi e la carnagione bianca e rosea, l’avevano distinta agli occhi degli spettatori come una creatura di notevole fascino. Prima che trascorressero 15 giorni, tanto concordi erano stati gli elogi della critica e così regolari gli applausi del pubblico che il Balletto degli uccelli divenne il Balletto della canarina e la signorina Odell fu promossa al rango di quella che caritatevolmente potrebbe esser definita première danseuse, con l’attribuzione di un valzer in assolo e una canzone interpolata appositamente perché desse prova delle sue molteplici grazie e talenti.
Alla chiusura della stagione, la ballerina aveva lasciato le Folies e, durante la successiva e spettacolare carriera nei luoghi di ritrovo della vita notturna di Broadway divenne popolarmente e familiarmente nota come la Canarina. Fu così che, quando la trovarono brutalmente strangolata nel suo appartamento, il delitto fu definitivamente denominato: l’omicidio della Canarina” (S.S. Van Dine, The Canary Murder Case,“La Canarina Assassinata”, trad. Pietro Ferrari, Il Giallo del Lunedì, L’Unità/Mondadori, 1992, pag.7).
La Canarina è Margaret Odell, attricetta e soubrette di locali di serie B, di night club, che è poi diventata famosissima in certi ambienti di Broadway. Conosce il suo ruolo e sa quale sia anche il giudizio che le riservano negli ambienti borghesi di cui lei rappresenta il richiamo: nel balletto non fa altro che fare il verso ad un uccello e mostrare le gambe. Ma si illude di poter scalare la società e conquistare un suo posto importante. E’ un po’ lo stesso discorso che fa la puttana di un Bordello di lusso (la prostituta sogna un amore impossibile con un bel cliente che oltre che utilizzarla per il suo piacere, la introduca nel mondo “normale”) il discorso di Margaret Odell, che, finito lo spettacolo, si ritrova nel grigiore della vita i ogni giorno, da cui esce temporaneamente solo nel volgere di uno spettacolo in cui uomini facoltosi in ghette, cilindro e marsina, fanno la coda per vederla , magari dondolarsi su un’altalena, su un trespolo, su cui lei, La Canarina, mostra le gambe.
E’ chiaro quindi che Margaret Odell, come farebbe una qualsiasi mantenuta, cerchi qualcuno che le assicuri, almeno nel suo mondo fatto di lustrini e pailettes, una certa onorabilità e almeno l’illusione di aver scalato quella società che invece non la accetterà mai. E’ la società degli anni ‘venti, in cui la grande crisi economica portò sul lastrico decine di migliaia di persone, ma che favorì anche l’arricchimento maggiore di chi già era ricco.
La Canarina ha molte amicizia maschili e non lo nega: i suoi accompagnatori la sfoggiano come oggi si farebbe con una Ferrari Testarossa, le altre donne la invidiano o ne parlano male, lo immaginiamo, ma lei pensa di poter usare queste amicizie, per i suoi scopi, che sono quelli di far carriera. Ha raccolto le confessioni di chi stava tra le sue gambe, ed un bel giorno decide di far il gran passo: decide di forzare la mano ad uno dei suoi amanti, e metterlo con le spalle contro il muro. E’ facile pensare, e poi lo si saprà, a cosa aspiri La Canarina: non vuol più essere “La Canarina”, ma una signora del Jet-Set, appartenere a quell’ambiente di cui ha conosciuto “tanti validi esponenti”. Solo che non capisce una cosa molto semplice: chi mai sposerebbe una “Canarina”? Ma lei si illude. E come tale resta vittima dei suoi stessi sogni.
Un bel giorno “La Canarina” vien ritrovata morta, assassinata, strangolata.
L’immagine che ne da Van Dine è terribile:
“Il capo era rivolto all’indietro, come per una costrizione violenta…i capelli, disciolti, ricadevano dalla nuca sulla spalla nuda come la cascata raggelata di un liquido dorato; aveva perso ogni bellezza; la pelle era esangue, gli occhi vitrei; la bocca era aperta e le labbra convulse. Il collo, sui due lati della cartilagine tiroidea, mostrava orribili lividi scuri. La Canarina indossava un leggero abito da sera di pizzo Chantilly nero sopra ad uno chiffon color crema. Sul bracciolo del divano aveva gettato una cappa di un tessuto dorato, bordata di ermellino…a parte i capelli arruffati, una delle spalline dell’abito era stata strappata e il sottile pizzo del corpetto si era aperto in un lungo squarcio..una scarpetta di satin si era sfilata ed il ginocchio destro era contorto in dentro vero il divano, come se la poveretta avesse cercato di liberarsi dalla soffocante morsa del suo antagonista: Le sue dita erano ancora piegate,senza dubbio come nel momento in cui si era arresa alla morte” (S.S. Van Dine, “La Canarina Assassinata”, trad. Caterina Ciccotti, I Classici del Giallo, Barbera Editore, 2010, pag.22-23).
Dal sopralluogo effettuato dalla polizia emerge che mancano dei gioielli, che invece avrebbero dovuto esserci, secondo quanto afferma la sua domestica: quindi si è portati a identificare l’assassinio, come l’effetto di una rapina, o di un furto in appartamento, finito male (per Odell).
Tuttavia, questo è il giudizio della polizia per bocca del Procuratore Distrettuale di New York, F.X. Markham, che conduce le indagini. Di diverso avviso sarà il giudizio di Philo Vance, amico del Procuratore, osservatore imparziale e di geniali intuizioni, che salverà anche questa volta la Polizia da una figuraccia, e che invece sonderà una strada che nessuno aveva intravisto.
Philo Vance è una evoluzione di Sherlock Holmes, radicale: se eredita da Holmes l’attenzione ai particolari, agli indizi, non è però un applicatore integerrimo di essi. Infatti gli indizi che magari porterebbero a orientare le indagini in un certo verso, devono accordarsi ad una ricostruzione psicologica che in base ad essi spieghi tutti i quid rimasti insoluti. E per far questo, Philo Vance, diversamente da Sherlock Holmes, sonda l’anima e la mente dell’uomo, con l’attenzione che il buon Conan Doyle non aveva contemplato per il suo Sherlock Holmes. Si raffrontano così due diversi ideali: quello umanistico, attento alla psicologia e alle altre arti scaturenti dalla passione e dal gusto (Pittura, Scultura, Musica) di Philo Vance; e quello scientifico, analitico, di Sherlock Holmes.
Tuttavia, Philo Vance, osserva alcuni particolari, e in virtù della sua capacità di vedere al di là del mero indizio, ne dà una spiegazione tale che la visione di un omicidio susseguente ad un tentativo di rapina finisce per crollare miseramente.
Normalmente, quando si parla di questo romanzo, tutti individuano la sottigliezza del ragionamento di Van Dine, nella spiegazione della Camera Chiusa, in effetti “immaginifica”: spiegare non tanto come l’assassino e il testimone siano potuti entrare, quanto come essi siano potuti uscire, visto che il portiere quando va via, spranga sempre dal di dentro il portoncino che porta nel cortile interno al palazzo (l’uscita posteriore) con un chiavistello, in tale maniera che chiunque entri nel palazzo stesso, dopo la sua uscita, debba passare per forza davanti al centralinista, impressiona; e impressionò in quel tempo, moltissimo.
Ma ancor di più impressionò il pubblico dei lettori (e dei critici) l’aver inventato un modo che dilazionasse in avanti nel tempo l’azione delittuosa, cioè dopo che il suo accompagnatore della sera assieme al centralinista l’avessero sentita parlar e rispondere alle domande fatte da loro fuori della porta.
Se tuttavia la soluzione della Camera Chiusa e l’espediente per far apparire accaduto dopo, un omicidio che era stato invece commesso prima, rappresentano i mezzi con cui l’investigatore inchioda l’assassino, e che sono messi in chiaro da chiunque analizzi questo romanzo, pochi, pochissimi o nessuno, hanno esaminato gli altri momenti della deduzione vandiniana.
Secondo me, un altro momento in cui Van Dine impressiona il lettore è quando fa argomentare Vance molto molto sottilmente, sulla posizione relativa al corpo della vittima e sugli strappi subiti dai suoi abiti: se davvero Margaret Odell fosse stata affrontata in un corpo a corpo, immaginando che si sarebbe difesa con tutte le proprie forze, per quale motivo un innocente mazzolino, che le è stato ritrovato in grembo, non sarebbe stato scagliato altrove? Per terra, per esempio? E inoltre se così fosse stato, il collo non sarebbe stato rivolto all’indietro, ma la vittima sarebbe dovuta cadere avanti. Quindi… il delitto non si è consumato così, e si è tentato, con una messinscena, di depistare le indagini: lo strangolamento è avvenuto dal di dietro, quando la vittima non si aspettava che chi le stava dietro la strangolasse, ergo si fidava di lui/lei. Ma ci sono gli strappi del vestito! Altra messinscena: gli strappi sono stati fatti post-mortem per confondere il ragionamento degli investigatori.
Secondo ragionamento molto sottile è quello, concernente la chiave dell’armadio: per quale motivo essa è posta internamente all’armadio, quando comunemente essa invece dovrebbe esser infilata nella serratura esternamente?
C’erano quindi, quella sera, in quella stanza, tre persone: Margaret Odell e due altre persone, di cui una nascosta nell’armadio. Chi è stato l’assassino e chi il testimone? L’assassino ha anche rubato in un secondo tempo, oppure è stato l’altro a rubare? Le due persone presenti nell’appartamento, nei loro diversi ruoli, sono legate ad un altro ragionamento che si fa largo allorché Philo Vance nota come un porta-documenti sia vuoto, e come un portagioie di acciaio sia stato apparentemente forzato con un attizzatoio di ghisa: se davvero ci fosse stato un ladro avrebbe certamente usato uno strumento più idoneo per far saltare il coperchio, piuttosto che usare un attizzatoio. Tanto più che un esperto chiamato da Vance ne corrobora la tesi: che cioè vi son stati due momenti diversi nell’effrazione: quello rozzo con l’attizzatoio, che non ha sortito altri effetti se non di ammaccare il coperchio, e quello altamente professionale, effettuato con uno strumento di acciaio, probabilmente un grimaldello. Perché mai si sarebbe dovuto portare dalla camera vicina un attizzatoio inadeguato a far quello che ha fatto il grimaldello?
In parole povere, Vance postula l’azione in due momenti separati, da parte di due diverse persone. Ecco una primo fatto accertato, di grande importanza: nell’appartamento, quella sera, la sera del sabato, due persone sono state lì, probabilmente in un tempo successivo alla morte della Canarina. Il che non vuol dire necessariamente che entrambi avessero partecipato all’omicidio.
Fatto sta che il secondo ignoto visitatore sarà ucciso e solo dopo la sua morte Vance, individuando l’espediente per ritardare la morte, darà un volto all’assassino. In questo caso l’espediente sarà direttamente messo in relazione all’attività dell’assassino.
Secondo me, fu proprio questo espediente, e non invece la soluzione della Camera Chiusa, a determinare il successo del romanzo. La ragione? L’espediente era legato ad un oggetto, che in quei tempi, negli Anni Venti, stava vivendo un’affermazione roboante e che era uno degli status symbol di una famiglia agiata, almeno di posizione sociale borghese. Un oggetto legato alla musica. Era difficile, assai difficile per non dire impossibile che una famiglia operaia o di assai modeste condizioni coltivasse la musica, mentre in una famiglia di estrazione medio-alto borghese la musica era una delle componenti anche sociali che le permettevano distinguersi da un’altra inferiore.
E non è un caso che accadesse che proprio Philo Vance si interessasse a quell’oggetto, disdegnato dagli altri rappresentanti dell’ordine, dall’ottuso Sergente Heath al troppo conformista Procuratore Markham.
Ma perché Philo Vance sì e gli altri no? Perché Philo Vance è un esteta, è interessato a quelle arti che per il povero Markham non rappresentano invece alcuna fonte di diletto. Vance è un individuo superiore, un cavaliere, un principe rinascimentale, superiore a tutti, anche al procuratore Markham: il solo che gli possa stare alla pari è Van Dine stesso, rinchiuso nella corazza del segretario.scudiero narratore delle sue gesta.
L’esser un coltivatore di arti lo mette su un gradino più altro del volgo con cui si rapporta.
Philo Vance è l’immagine del Super Uomo Nietzschiano, di cui Wilard Huntigdon Wright era profondo conoscitore, avendo curato la prima edizione integrale americana delle opere del pensatore tedesco. Proprio queste arti o i giochi che egli pratica (il gioco degli scacchi, che è strumento dell’arte del pensiero, del ragionamento, sarà alla base di The Bishop Murder Case; mentre il poker giocherà un certo ruolo nella classificazione psicologica dell’omicida, in The Canary Murder Case).
Individuo in questo romanzo 4 caratteristiche peculiari di Vance: la deduzione (soluzione della Camera Chiusa), la psicologia (il ragionamento che scaturisce dalla partita a poker), la curiosità (la scoperta dell’imballo dei dischi in un cestino della carta straccia), la sensibilità artistica.
Infatti, al di là di come egli dimostri in maniera incontrovertibile il modo per uscire dal portoncino lasciando il chiavistello chiuso dall’interno; al di là del fatto che egli usi l’elemento psicologico derivante da una partita a poker per insinuare la colpevolezza di una certa persona, non riuscirebbe mai a provare le sue accuse se…un elemento puramente casuale non gli desse una mano.
Può un fattore affidato al caso avere la meglio sulla psicologia finissima e sulla superiore deduzione di Philo Vance? E’ questo il punto. NO.
Eppure in questo caso, la superiorità potrebbe esser affermata. Tuttavia, metto in rilievo come la personalità di Philo Vance sia determinata dall’unione di una molteplicità di fattori (le 4 caratteristiche peculiari) : tra questi la sensibilità artistica ha un peso assolutamente non indifferente, e nel caso nostro è assolutamente determinante. Sensibilità artistica che in questo romanzo, pur facendo capolino qua e là, come se si nascondesse per non essere inquadrata come elemento caratterizzante del tutto, nel finale gioca un ruolo di primo piano.
Tutto questo per affermare cosa? Semplicemente che in questo romanzo, cosa trascurata colpevolmente da molti critici, il fattore più importanti di tutti, per determinare la colpevolezza di una tale persona in rapporto ad altre, è proprio la sensibilità artistica di Philo Vance. Che è sensibilità letteraria (di citazioni se ne trovano a bizzeffe, sia di opere latine, che francesi, tedesche), sensibilità verso le arti figurative, scultoree e di altri tipi di manufatti artistici, es. i tappeti, le porcellane. E ancor più, direi più manifestatamene in questo romanzo, la sensibilità artistica di Vance è sensibilità musicale.
Nel vissuto dell’indagine, si può apprezzare il peso della sensibilità artistica di Vance, nelle sue valutazioni relative alla idiozia di usare delle pergamente per confezionare un cestino per la carta straccia, poi alla fattura dei tappeti, e infine in valutazioni di tipo musicale.
Philo Vance è nell’appartamento della Canarina. E’ alla ricerca di qualcosa, ma non sa cosa. Sa chi possa essere l’omicida, anzi ne è sicuro dopo aver giocato a poker, con quelli che in questo dramma hanno un ruolo, cioè gli amanti della Canarina. Ma il sapere chi sia, non significa nulla, perché egli al momento non ha modo di provare come quella persona possa essere accusata del suo omicidio, perché una situazione assolutamente lampante lo metterebbe fuorigioco: una persona, estranea al gioco, che era con lui e che affermerebbe anche sotto tortura, assolutamente in buona fede, che l’omicida era in sua compagnia, in un certo momento. Ecco allora perché va a bighellonare a casa della vittima, assieme a Markham. E’ proprio in questa situazione che gli si accende la lampadina.
Tra tutti i gusti, quelli musicali di Vance, qui, hanno una importanza determinante: infatti se Vance non fosse edotto e conoscitore di musica classica, la soluzione gli sfuggirebbe. Nondimeno è da mettere in rilievo come, dall’altra parte, se l’omicida avesse seguito un altro iter di pensiero, sicuramente Vance non avrebbe avuto modo di provare la sua colpevolezza.
Entra in gioco, quindi un altro elemento, nella definizione delle responsabilità: il Fato; a cui non si sfugge:
- è il Fato a dettare il fatto che l’omicida abbia buttato una confezione nel cestino della carta straccia; ma, se questo fosse stato un cestino qualunque, Vance non si sarebbe interessato ad esso: egli nota che è fatto di pergamena. Per un altro questo particolare non significherebbe nulla, ma per uno come lui che ha una sensibilità innata per tutto ciò che è bello e fine, esteticamente parlando, quel cestino di pergamena è un affronto. Quindi decide di guardarvi dentro, e trova uno sgualcito foglio di carta da pacchi ed un largo involucro quadrato marrone.
- Se Vance non si interessasse di musica, non frequentasse i teatri e non si recasse a sentire concerti, non potrebbe arguire che si tratti di un involucro di dischi. A questo punto ecco che si affaccia il fantasma della musica: sarà la predisposizione musicale e i gusti dell’assassino e del detective a sancire la soluzione dell’enigma.
Vance chiede a Markham dove sia il grammofono (perché se c’è un disco dev’esserci un
grammofono). Saputa la risposta, lo cerca con lo sguardo. Il grammofono è nell’anticamera;
su di esso è appoggiato un tappetino sormontato da una boccia per fiori.
- Se Vance non fosse stato un esperto d’arte, non si sarebbe mai interessato a quel tappeto. Ma è anche da mettere in rilievo che se l’omicida per evitare che qualcuno guardasse dentro il grammofono non avesse messo un tappetino ed una boccia per fiori, probabilmente l’attenzione di Vance non sarebbe stata catturata. Egli nota infatti che è “..anatolico, probabilmente spacciato per un tappeto del Kaysari per ragioni puramente commerciali. Non vale un granchè, troppo simile al tipo Ushak..” (S.S. Van Dine, “La Canarina
Assassinata”, trad. Caterina Ciccotti, I Classici del Giallo, Barbera Editore, 2010, pag. 249).
Schifato dall’esteriorità priva di qualsiasi rilievo artistico e dettata solo dalla legge dell’apparenza, Vance si chiede quale musica mai sentisse La Canarina: “..Mi domando quali fossero i gusti musicali della signorina. Victor Herbert, senza dubbio”( idem, pag. 249).
Chi era Victor Herbert a quel tempo? Un compositore, animatore della vita musicale soprattutto newyorkese, autore di operette e anche di musiche molto conosciute, tipo “Serenades of All Nations”, cantate e danzate da ballerine. Comunque sia un tipo di musica alternativa a quella “seria”. Ecco che a questo punto si realizza il disegno del Fato che oppone la scelta sbagliata dell’omicida (ma sbagliata perché?) alla curiosità musicale di Vance:
- Se Vance non fosse stato un amante della Musica colta non sarebbe mai stato attratto da Beethoven: “…Parola mia! L’Andante della Sinfonia in Do minore di Beethoven! –esclamò allegramente. – Conosci sicuramente il motivo, Markham. Il più perfetto andante che sia mai stato scritto!” (idem, pag. 249). La sorpresa di Vance è ancora più marcata in quanto fino ad allora ha notato un senso estetico della Canarina quanto mai riprovevole ai suoi occhi: quindi i gusti musicali di Odell, Beethoven, sono per lui uno shock..positivo. E decide di sentire il disco.
Ma i gusti musicali della Canarina, scopriremo che probabilmente erano quelli ipotizzati in un primo tempo da Vance. Non è stata lei a mettere il disco con l’etichetta di Beethoven, ma..il suo assassino. Tuttavia egli non avrebbe mai potuto pensare che nella sfortuna di avere incontrato la Canarina, di esserne diventato accompagnatore e amante, e poi ricattato, egli sarebbe stato doppiamente sfortunato nell’aver fatto una scelta che in una situazione normale, sarebbe stata felice. La sfortuna sta nel suo caso, nell’aver incrociato dall’altra parte un fine esteta e conoscitore di arte e di musica come Vance: se ad accompagnare Markham fosse stato un qualsiasi altro tipo, dotato di comuni gusti estetici, nel 99% dei casi sicuramente non avrebbe mai voluto sentire Beethoven. La sfortuna quindi dell’omicida sta nell’esser stato opposto a chi era attratto proprio da quei gusti musicali.
Ecco perché nella soluzione de “La Canarina assassinata”, la propensione di Vance verso la sensibilità artistica, e soprattutto musicale, gioca un ruolo fondamentale. Non disgiunta, come abbiamo visto dalla casualità preordinata dal Fato.
Il Fato che è la Forza a cui soggiacciono uomini e dei; il Fato che, come un ingranaggio invisibile ma inesorabile, lega i soggetti alle loro azioni; il Fato infine che è l’interprete per antonomasia della grande tragedia greca. Questa, della Canarina, non è una grande tragedia ma una piccola. Pur sempre di tragedia tuttavia si tratta; e non di dramma. Il Dramma ha uno sfogo, che può essere positivo o negativo; la Tragedia invece non ha soluzioni positive: è sempre negativa, sia per gli innocenti che per i colpevoli. E qui i colpevoli e gli innocenti muoiono alla stessa maniera: è innocente Odell e colpevole X? Oppure è colpevole la prima e innocente il secondo? Niente di tutto questo: nel romanzo, colpevoli e innocenti si confondono, invece di esser ben demarcati.
E in quanto attori di una tragedia, i vari interpreti talora si muovono in quanto soggiogati da una volontà che è al di sopra di loro, e a cui non sfuggono.
Al Fato, per me, è collegato il riferimento musicale esplicitato dalla etichetta sul disco, l’Andante in Do minore, della 5^ Sinfonia di Beethoven: la tonalità di Do minore, che è di per sé una tonalità funerea, molto spesso usata per i Requiem (assieme al Re minore, più usuale), diventa in Beethoven la tonalità dell’eroe. La Sinfonia è però detta anche “del destino che bussa alla porta”: un altro riferimento al Fato. Al Destino. A qualcosa che sta per compiersi.
Alla fine del romanzo lo ammetterà lo stesso assassino che : “Ho pensato che se qualcuno, per qualunque evenienza, avesse aperto il grammofono prima che potessi tornare a distruggere il disco, difficilmente avrebbe desiderato ascoltare della musica classica, e avrebbe sicuramente optato per qualcosa di più popolare.
– E doveva trovarlo proprio uno che detesta la musica leggera! Temo…che un destino maligno abbia presieduto a questo suo gioco.
– Sì…se avessi delle inclinazioni religiose, potrei dire qualche sciocchezza sulla ricompensa e sul castigo divino.” (idem, pag. 261)
Di riferimenti musicali ve ne sono però anche altri, disseminati qua e là.
Intanto ve n’è uno che richiama Mozart. Nel cap. VII, leggiamo che la cameriera di Odell viene interrogata formalmente alla presenza di Vance da Markham e parla di un tale, un ex innamorato della Odell, che si vestiva all’ultima moda, che l’andava spesso a trovare e riusciva a scucirle sempre dei soldi.. Vance parlandone a Markham, poco dopo, usa un aggettivo italiano (nel testo il termine è scritto in italiano), assai poco usuale, che una persona che abbia una certa cultura, anche musicale, sentendolo, assocerà sempre a Mozart. Vance infatti dice: “..Quasi ogni Dalila dei giorni nostri ha un avido amoroso..” (idem, pag. 61).
L’aggettivo “amoroso” a me richiama in mente, subito, un’Aria di Mozart dall’Opera Le Nozze di Figaro, con cui termina il Primo Atto dell’Opera, e che comincia con : “Non più andrai, farfallone amoroso, notte e giorno d’intorno girando; delle belle turbando il riposo Narcisetto, Adoncino d’amor”. E sicuramente al “farfallone” mozartiano vuole idealmente riferirsi Vance, anche se lui usa il termine “gigolò”, in riferimento al fatto che il personaggio nominato, chiedeva soldi alla Odell (ma non la ricattava).
Nella stessa frase potrebbe celarsi anche un altro riferimento musicale: Vance, associa a Odell, il nome “Dalila”. Sappiamo tutti che Dalila era la Filistea, quasi una Mata-Hari dei tempi nostri, che tramite la sua bellezza riuscì a far invaghire di sé Sansone: il riferimento potrebbe essere riferito tuttavia anche all’opera lirica di Camille Saint-Saens : “Samson et Dalila”, che durante la Stagione 1915/16, era stata rappresentata a New York, al Metropolitan Opera, con Margarete Matzenauer (Dalila) e Enrico Caruso (Sansone).
Poi vi sono altri due riferimenti musicali.
Il primo è un brano per pianoforte solo. Prima infatti che Vance si interessi al cestino della carta straccia, ha notato un pianoforte, e sedutosi, vi suona l’attacco del “Capriccio n.1” di Brahms.
Il Capriccio n.1 è il primo di otto brani dell’op.76. E’ in Fa diesis minore, una tonalità che potremmo definire “dolorosa”, talora anche “straziante”: il diesis è come se accentuasse il dolore del Fa minore portandolo ad un punto di non ritorno. Potrei anche dire che per taluni, il Fa diesis minore è la tonalità della tragedia, ma la cosa sembrerebbe troppo voluta. Limitiamoci quindi al brano in sé per sé. E’ un pezzo in arpeggi, di grado abbastanza difficile. Che significa? Che Vance non è un semplice amatore delle cose belle, non è un dilettante erudito, ma un colto professionista: il pianoforte lo sa suonare, e suona per di più un brano difficile. In altre parole, anche la musica, come la pittura, la scultura, le conoscenze in porcellane, tappeti, etc.. non vengono mai praticate da Philo Vance esteriormente, ma sempre con un grado di conoscenza che lo qualifica non solo nei confronti del volgo ignorante ma anche nei confronti di altri esteti come lui.
Il secondo riferimento musicale attiene ad una cosa che mi si è mostrata lampante e a cui anni fa, quando lessi per la prima volta il romanzo, non detti importanza : la somiglianza, sicuramente non casuale, tra Margaret Odell, ballerina in rapida ascesa, e l’alter ego della Principessa Odette, interprete del famoso balletto musicato da Tchaikowsky: Odile, il Cigno Nero, la figlia del mago Rothbart che vuole sostituirsi a Odette per rubargli l’amore del Principe Derek.
Odile-Odell, non sono solo due nominativi molto simili, ma che sono anche collegabili, la prima alla seconda, anche per il fatto che si richiamano a due volatili: un cigno ed una canarina. Come il Cigno Nero con le arti magiche fa in modo che Derek la veda come Odette, quindi il male si traveste da bene, anche Odell che sembrerebbe essere pura come il suo canto, in realtà ha l’anima nera come il peccato.
Odile-Odell sono ambedue rapportabili quindi a Odette e insieme formano una triade ideale: Odile-Odell-Odette.
Odile e Odell ambiscono ambedue a identificarsi in Odette. Se all’identificazione di Odile, abbiamo accennato, vi è tuttavia anche quella nascosta di Odell: infatti la Odette di Odell è lei stessa trasformata in un personaggio positivo, che la società accetta e riconosce.
Considerando i tre personaggi, possiamo vedere come ad essi sia singolarmente ma anche nell’ambito del loro rapporto vicendevole, possa applicarsi la “Teoria del Desiderio Mimetico” di René Girard, soprattutto quando verifichiamo meglio quali siano soggetto, oggetto e mediatore.
Girard, trovò la caratteristica comune nella letteratura: il Desiderio. Il desiderio non è mai espressione diretta del soggetto, ma è il riflesso del desiderio di qualcosa da parte di altri. Nella sua espressione si affrontano due momenti alternativi: quando l’oggetto del desiderio è lontano, il soggetto (che desidera quello che vuole il mediatore) ed il mediatore possono coesistere in pace; quando invece l’oggetto del desiderio tra i due è vicino, sul loro stesso piano, emerge una conflittualità.
Così possiamo applicare la Teoria del Desiderio Mimetico anche al romanzo in oggetto.
Innanzitutto prendiamo in esame la Triade: Odette è l’oggetto desiderato, sia da Odile che ambisce ad identificarvisi per rubarle l’amore di Derek, sia metaforicamente da Odell, che vorrebbe trasformarsi da insulsa Canarina in un Cigno e possedere l’amore di un principe come Odette. Quindi in questo caso avremmo la “Mediazione esterna”: Odell desidera di essere Odette, ed il mediatore del desiderio è Odile, che a sua volta ambisce a trasformarsi in Odette. Mediatore e soggetto, sono un qualcosa di incompiuto, e come tale ambiscono a trasformarsi nell’oggetto del desiderio, tramite un raggiro (Odile si trasforma in Odette grazie ad una illusione, Odell ambisce a trasformarsi in Odette grazie ad un ricatto). Siccome Odette è un desiderio che può essere lontano, i due personaggi non si scontrano sul piano ideale.
Tuttavia se andiamo a verificare i due casi singoli, la mediazione è ancor più evidente:
in Tchaikowsky, per esempio, il soggetto che desidera è Odile, l’oggetto desiderato è il Principe Derek, mentre il mediatore del desiderio è Odette. Secondo René Girard, ricadremmo nella cosiddetta “mediazione interna” caratterizzata da un elevato scontro di carattere sempre più violento e parossistico man mano che le due sfere, i due desideri che tendono al medesimo oggetto, venissero a contatto. Una caratterizzazione simile, però, la ritroviamo anche nel romanzo di Van Dine, e più precisamente nel rapporto che lega Margaret Odell al suo oggetto. Anche qui troviamo applicata la “mediazione interna”: Margaret Odell, il soggetto, brama l’oggetto, che è la stabilità economica e sociale. Questo è anche l’oggetto del mediatore “X”. I due, soggetto (Odell) e mediatore (X) vengono in contrasto sull’oggetto del contendere e questo contrasto è tanto più forte quanto maggiore è la brama del soggetto, cioè di Odell, di possederlo. Così vengono a scontrarsi la voglia di un nuovo status sociale con la volontà che la stabilità del vecchio, coincidente con gli affetti familiari di “X”, venga mantenuta. Il contrasto è tanto più alto e tanto più senza uscita, perchè per piegare le difesa di X, ci si serve del ricatto.
Odile-Odell sono unite anche da un altro rapporto: entrambe sono ballerine, ma il loro rapporto col ballo è antitetico: per la prima, Odile, dalla tragedia scaturisce il ballo; per la seconda, Odell, dal ballo scaturisce la tragedia, dalle amicizie che lei ha costruito sulla sua attività di ballerina.
Sempre legato alla musica è l’uso del grammofono, fino ad allora espressione di un mondo frivolo, salottiero, che uscito dalla Prima Guerra Mondiale non si era ancora affacciato a quella che sarà la Grande Depressione del 1929. Fino ad allora, nessuno aveva mai pensato di servirsene per altro scopo che non fosse stato quello di riprodurre musica; dopo Van Dine, invece…
Voglio ricordare innanzitutto Agatha Christie e il suo And Then There Were None del 1939: qui il procedimento che sottende all’uso del grammofono è inverso. Infatti così come in Van Dine l’uso del grammofono è quello di creare un’illusione, cioè dimostrare al portiere dell’albergo che a quell’ora, la Canarina era ancora viva (mentre non lo era più), quella che si potrebbe definire coloristicamente “una voce dall’Oltretomba”, in And Then There Were None di Agatha Christie, la voce di Mr. Owen (il padrone di casa) incisa su un disco, e amplificata dal grammofono, vanamente aspettato dai dieci presenti, ha il compito di creare un’illusione opposta, cioè dimostrare alle dieci persone presenti, che la persona che parla attraverso la voce registrata sul disco, non sia materialmente presente in mezzo a loro, cosa che invece è.
Se tuttavia la Christie si serve dell’espediente vandiniano piegandolo ai propri interessi, in altra occasione, precedente al romanzo della Christie, l’illusione del grammofono viene ricreata con un oggetto che negli anni ’30 aveva in gran parte soppiantato il primo: la radio. Se ne serve Clayton Rawson per generare altra illusione, in Death from a Top Hat, 1938. E ancora precedente ai due, un altro romanzo, nel 1930, era ricorso all’espediente della radio, collegata però a dei grammofoni occultati: The Invisibile Host, di Bristow & Manning.
Infine, talora, Vance fa sfoggio anche di letture colte. Un caso è quello presente nel cap. VIII, laddove Vance e Markham continuano a disquisire in merito alle impronte lasciate nella neve: “Grau, teurer Freund, ist alle Teorie” declama Philo Vance. Il passo è uno dei più famosi del Faust di Goethe. Ma è solo la metà quello che cita Vance. Il passo intero sarebbe : “Grau, teurer Freund, ist alle Teorie, Und grün des Lebens goldner Baum”, cioè letteralmente : “Caro amico, tutta la teoria è grigia, e verde l’albero d’oro della vita”. Vance cita però la prima parte perché da lui viene adattata al discorso che sta tenendo a Markham , che verte sull’assenza di impronte sulla neve e sulla mancanza di testimonianze su chi le avrebbe dovute lasciare, cioè su come Markham non possegga né prove dirette né prove indiziarie (=la teoria è grigia).
Non è il solo passo. Ve ne sono parecchi altri.
Per es. ad un certo punto del cap.10, dice: “Forse sì. Potrebbe figurare come un moderno Cayley Drummle”. Chi è Cayley Drummle? Si dovrebbe conoscere il dramma di Arthur Wing Pinero, The Second Mrs.Tanqueray per sapere chi fosse, ma né Van Dine né i traduttori lo dicono. Il primo non lo dice perché nel colloquio che tiene a Markham, il senso del discorso eventualmente viene compreso; e del resto se i riferimenti cui alludesse non fossero criptici, non si potrebbe alludere alla enciclopedica cultura di Van Dine; i secondi invece non sciolgono il quesito perché probabilmente non lo sanno e non ritengono per forza di andarsi a sobbarcare di un inutile onere (neanche riconosciuto nel pagamento della traduzione, immagino).
Il punto però è che il lettore medio che legge Van Dine, trovandosi dinanzi a queste digressioni, a questi rimandi colti, a queste citazioni, non è tenuto per forza ad avere pari enciclopediche virtù di Van Dine e di Philo Vance. Per cui o il traduttore è così sensibile da andarsi a documentare oppure il lettore o dovrà farlo se vorrà cogliere tutto quanto espresso da Van Dine oppure sarà costretto a saltare a piè pari quando si troverà costretto a tali imbarazzanti confronti.
Tutto ciò mi da modo di mettere in risalto il fatto che contrariamente a quanto si dice, i Gialli di S.S. Van Dine non sono affatto così facili da leggere; tutt’altro!
Ancora, leggiamo:
“– E’ piuttosto tardi, l’ammetto, ma perché non acciuffare il momento opportuno per i capelli, come consiglia Pittico?
Perde la fortuna chi lascia la sua morsa
poiché calva è dietro, l’occasion trascorsa”.
Ma Catone il Vecchio ha anticipato Cowley. Nei suoi “Disticha de moribus” ha scritto: Fronte capillata..” (pagg.80-81, op. cit., trad. Ferrari).
Il distico attribuito a Pittico capiamo che dev’essere messo in relazione con Cowley. Ma chi è costui, direbbe Don Abbondio? Nessuno ci dice che è uno dei più grandi poeti inglesi del Seicento.
Meno male che il capitolo 10 finisce con Catone il Vecchio di cui almeno viene citata la fonte del riferimento, “I Distici” (anche se attualmente una parte della critica mette in dubbio che l’autore sia proprio Catone il Vecchio).
Così sappiamo che Vance, volendo cogliere l’occasione propizia al volo, il momento opportuno, non cita né Lorenzo il Magnifico né tantomeno Orazio (perché l’occasione propizia, il momento opportuno legato alla fortuna non è proprio pari al Carpe Diem nei due autori), ma Abraham Cowley e Marco Porcio Catone: il riferimento di Cowley risiede proprio nel distico catoniano: “Rem, tibi quam noris aptam, dimittere noli: Fronte capillata, post est Occasio calva” (Non permettono ciò che consideri buono per le tue fughe; l’occasione ha i capelli sulla fronte, ma dietro è calva” Distici, Libro 1, 2,26).
Perché? Neanche questo dice Van Dine. Perché si aspetta che il suo lettore lo sappia o lo immagini: il fatto è che il distico catoniano è da mettere in relazione con la Dea Fortuna secondo i romani: cioè i capelli appesi sulla fronte e la nuca calva, oltre che essere sinonimi di giovinezza e vecchiaia, lo sono anche di buona e cattiva fortuna. Tuttavia “occasione=occasio” è espressa con il sostantivo latino che comincia con maiuscola, a significare un nome, che si riferisce ad una dea, l’Occasione, messa in relazione con quella greca Kairos (καιρός), una divinità minore del tempo:“il momento opportuno”.
![]() Un breve discorso a parte merita invece il passo:
Un breve discorso a parte merita invece il passo:
“– Forse perché ne era innamorato – sorrise Markham.
– Un po’ come Ambra, eh?..
Pronta era Ambra prima di chiamarla:
Ambra venne, che un’altra io chiamavo”.
Neanche del distico inserito, Van Dine attraverso Vance informa il lettore. E siccome il traduttore di turno non si pone il problema cosa stia traducendo, ecco che il lettore deve accettare senza capire nulla o quasi di ciò che legge. Siccome io leggo sempre tutto il testo e mi soffermo sui passi, mi son posto il problema che altri non si son posti: chi era Ambra? Una creatura mitologica amata da Ombrone. Mi son ricordato di un poemetto in ottave che compose Lorenzo il Magnifico e che si chiamava Ambra. Possibile che..?
No. Non si tratta di quel poemetto. E allora..? A questo punto sento il bisogno di confrontare il passo originale: Van Dine ha scritto veramente Ambra oppure altro?
Mi corre in aiuto un mio amico d’oltreoceano, John Norris, blogger come il sottoscritto, che mi fornisce il distico in lingua americana (prima edizione, Scribner, 1927):
“Abra was ready ere I called her name;
And, though I called another, Abra came.”
Abra quindi, non Ambra. Perché abbiano tutti tradotto Abra come Ambra è un mistero: Ambra in inglese (e americano) si dice Amber, non Abra.
Ecco allora che la provenienza è diversa: Solomon on the Vanity of the World. Book II, Verso 364, di Matthew Prior, un grande poeta inglese vissuto a cavallo tra il diciassettesimo ed il diciottesimo secolo, che viene immediatamente prima di Alexander Pope (chi fosse interessato al poema, ecco il link, perché è di pubblico dominio: http://www.poetrycat.com/matthew-prior/solomon-on-the-vanity-of-the-world-a-poem-in-three-books—pleasure-book-ii.).
Vance quindi modello di eleganza, di sensibilità artistica, di conoscenza della musica, di conoscenze letterarie, tanti concetti compresi in uno solo: erudizione, che in questo romanzo (anzi, nei romanzi) di Van Dine, è presente in gran quantità. Ciò può essere divertente, interessante, ma anche talora irritante.
Non diremmo noi stessi, impegnati a leggere le avventure di Philo Vance, in fondo, quello che dice il suo interlocutore ?
“Andiamo! – supplicò Markham alzandosi. – Qualunque cosa pur di arginare questo profluvio di erudizione” (S.S. Van Dine, The Canary Murder Case, La Canarina assassinata – trad. Pietro Ferrari, I Gialli del Lunedì, L’Unità/Mondadori, pag. 81).
La traduzione di questo volume dei bassotti è di Pietro Ferrari (Mondadori).
PIETRO DE PALMA


 Le Géant de Pierre (L’omicidio di Atlantide), quando fu pubblicato, determinò un piccolo giallo. Diciamo un giallo in famiglia. Allora ero molto da vicino a Igor Longo, che in quel tempo era uno dei consulenti editoriali Mondadori più seguiti. Mi ricordo che Igor era rimasto contrariato dal fatto che il romanzo fosse uscito in autunno, mentre lui aveva caldeggiato che uscisse d’estate. Perché? Perché nella geografia del poliziesco, ci sono romanzi che è meglio escano d’estate ed altri in inverno: di solito i romanzi più complessi, più drammatici si inseriscono (o si inserivano) nella programmazione autunnale-invernale, mentre quelli più leggeri venivano pubblicati d’estate.
Le Géant de Pierre (L’omicidio di Atlantide), quando fu pubblicato, determinò un piccolo giallo. Diciamo un giallo in famiglia. Allora ero molto da vicino a Igor Longo, che in quel tempo era uno dei consulenti editoriali Mondadori più seguiti. Mi ricordo che Igor era rimasto contrariato dal fatto che il romanzo fosse uscito in autunno, mentre lui aveva caldeggiato che uscisse d’estate. Perché? Perché nella geografia del poliziesco, ci sono romanzi che è meglio escano d’estate ed altri in inverno: di solito i romanzi più complessi, più drammatici si inseriscono (o si inserivano) nella programmazione autunnale-invernale, mentre quelli più leggeri venivano pubblicati d’estate.
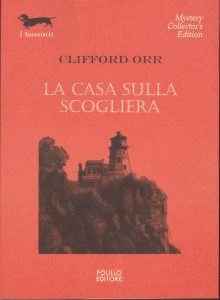
 Siccome ci sono anche lo sceriffo ed il vice sceriffo che presidiano la casa, Spider da la sua stanza allo Sceriffo mentre lui ottiene dopo varie insistenze che il padrone di casa gli consegni la chiave del portone di casa, della casa gemella. Che dovrebbe essere disabitata e dove invece ha visto un chiarore. Vi si reca e..trova Philip Masterson, uno degli amici della sua protetta, che dopo un colloquio, inaspettatamente, gli confessa di aver ucciso Garda. E gli da pure l’arma del delitto, un coltello affilatissimo in un astuccio d’argento. Spider vince la sua rabbia e la sua voglia di ucciderlo, ma il suo bastone da passeggio infrange il vetro della finestra della cupola e cade dabbasso. Spider, chiude il giovane nella stanza e va ad avvisare lo sceriffo, e anche a recuperare il bastone. Quando invece…qualcuno con lo stesso legno lo tramortisce. Si sveglia, assistito dallo sceriffo e viene a sapere che qualcuno mentre lui era svenuto, sicuramente il suo assalitore, ha ucciso Masterson. Il fatto è tuttavia che tutti avevano un alibi al momento della morte, in quanto erano nelle loro stanze e Masterson è scappato da una di esse per via di un terrazzino, che non hanno le altre. Sicuramente pensa Spaton Meech che qualcuno è riuscito a uscire con un artifizio dalla sua camera. Viene a sapere anche che c’è stata una sparatoria a casa Farnol, tra il vice sceriffo e qualcuno che si aggirava nei pressi della casa: questa persona è rimasta ferita, come testimoniano delle macchie di sangue. Quindi, siccome l’unico che può essere rimasto ferito, è chi lo ha aggredito e quindi ha ucciso Masterson, gli si mette alla ricerca. Individua del sangue sulla spalla della signora St.John, e partendo dal presupposto che solo il marito l’avrebbe toccata lì, ipotizza che l’assassino sia Richard St.John. In questo caso si prospetterebbe un tipico caso della Camera Chiusa, per come egli avrebbe fatto ad uscire dalla sua camera al primo piano dei Farnol e poi rientrarvi lasciando inserita dall’esterno finanche la chiave. Ma poi, scoprendo in Sutton l’uomo che l’ha lasciata, si convince della sua colpevolezza.
Siccome ci sono anche lo sceriffo ed il vice sceriffo che presidiano la casa, Spider da la sua stanza allo Sceriffo mentre lui ottiene dopo varie insistenze che il padrone di casa gli consegni la chiave del portone di casa, della casa gemella. Che dovrebbe essere disabitata e dove invece ha visto un chiarore. Vi si reca e..trova Philip Masterson, uno degli amici della sua protetta, che dopo un colloquio, inaspettatamente, gli confessa di aver ucciso Garda. E gli da pure l’arma del delitto, un coltello affilatissimo in un astuccio d’argento. Spider vince la sua rabbia e la sua voglia di ucciderlo, ma il suo bastone da passeggio infrange il vetro della finestra della cupola e cade dabbasso. Spider, chiude il giovane nella stanza e va ad avvisare lo sceriffo, e anche a recuperare il bastone. Quando invece…qualcuno con lo stesso legno lo tramortisce. Si sveglia, assistito dallo sceriffo e viene a sapere che qualcuno mentre lui era svenuto, sicuramente il suo assalitore, ha ucciso Masterson. Il fatto è tuttavia che tutti avevano un alibi al momento della morte, in quanto erano nelle loro stanze e Masterson è scappato da una di esse per via di un terrazzino, che non hanno le altre. Sicuramente pensa Spaton Meech che qualcuno è riuscito a uscire con un artifizio dalla sua camera. Viene a sapere anche che c’è stata una sparatoria a casa Farnol, tra il vice sceriffo e qualcuno che si aggirava nei pressi della casa: questa persona è rimasta ferita, come testimoniano delle macchie di sangue. Quindi, siccome l’unico che può essere rimasto ferito, è chi lo ha aggredito e quindi ha ucciso Masterson, gli si mette alla ricerca. Individua del sangue sulla spalla della signora St.John, e partendo dal presupposto che solo il marito l’avrebbe toccata lì, ipotizza che l’assassino sia Richard St.John. In questo caso si prospetterebbe un tipico caso della Camera Chiusa, per come egli avrebbe fatto ad uscire dalla sua camera al primo piano dei Farnol e poi rientrarvi lasciando inserita dall’esterno finanche la chiave. Ma poi, scoprendo in Sutton l’uomo che l’ha lasciata, si convince della sua colpevolezza.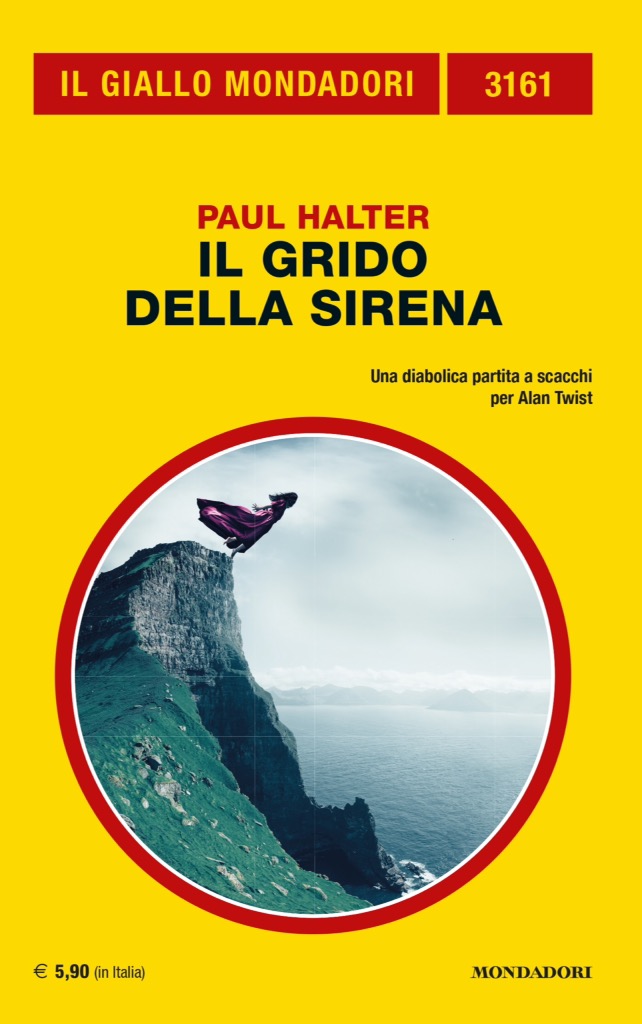 Un romanzo di Halter mancava da parecchio tempo in Italia: l’ultimo suo romanzo pubblicato fu Il Demone di Dartmoor, tre anni fa. Un’assenza incredibilmente lunga a fronte dei tanti aficionados italiani e della periodicità di uscita invece di altri romanzieri con meno credenziali. A fronte anche del fatto che in altri tempi i romanzi di Paul uscivano con ben altra cadenza: anche tre all’anno, nei tempi di Dazieri. E a fronte anche del fatto che manchino ben 21 inediti alla pubblicazione in Italia, 21 inediti che comprendono romanzi con Twist, con Burns (nessuno pubblicato in Italia), e romanzi senza personaggio fisso.
Un romanzo di Halter mancava da parecchio tempo in Italia: l’ultimo suo romanzo pubblicato fu Il Demone di Dartmoor, tre anni fa. Un’assenza incredibilmente lunga a fronte dei tanti aficionados italiani e della periodicità di uscita invece di altri romanzieri con meno credenziali. A fronte anche del fatto che in altri tempi i romanzi di Paul uscivano con ben altra cadenza: anche tre all’anno, nei tempi di Dazieri. E a fronte anche del fatto che manchino ben 21 inediti alla pubblicazione in Italia, 21 inediti che comprendono romanzi con Twist, con Burns (nessuno pubblicato in Italia), e romanzi senza personaggio fisso. Twist, accolto al castello, verifica lo stato dei luoghi, e soprattutto la stanza rosa, che, aperta, dimostra di non essere affatto impolverata e piena di ragnatele come ci si aspetterebbe, ma linda e pulita, e anzi fresca e profumata, in tutto e per tutto una camera che avrebbe potuto accogliere tra le coltri del letto a baldacchino un ospite. Twist riscontra soprattutto una cosa: il padrone di casa è veramente spaventato e prostrato da queste “presenze”. Del resto il castello è stato da altri tempi luogo maledetto: infatti sia colui che aveva sfidato il diavolo, sia il figlio, sono stati oggetto delle attenzioni della Banshee, un essere demoniaco, che più volte ha fatto sentire la sua presenza a Moretonbury: appare con un pettine rotto tra le mani, e lancia un urlo straziante. Dice la leggenda che chi non lo sente è destinato a morire. Sia il vecchio Cranston che il figlio non avevano sentito il pianto della Banshee, ed erano puntualmente morti.
Twist, accolto al castello, verifica lo stato dei luoghi, e soprattutto la stanza rosa, che, aperta, dimostra di non essere affatto impolverata e piena di ragnatele come ci si aspetterebbe, ma linda e pulita, e anzi fresca e profumata, in tutto e per tutto una camera che avrebbe potuto accogliere tra le coltri del letto a baldacchino un ospite. Twist riscontra soprattutto una cosa: il padrone di casa è veramente spaventato e prostrato da queste “presenze”. Del resto il castello è stato da altri tempi luogo maledetto: infatti sia colui che aveva sfidato il diavolo, sia il figlio, sono stati oggetto delle attenzioni della Banshee, un essere demoniaco, che più volte ha fatto sentire la sua presenza a Moretonbury: appare con un pettine rotto tra le mani, e lancia un urlo straziante. Dice la leggenda che chi non lo sente è destinato a morire. Sia il vecchio Cranston che il figlio non avevano sentito il pianto della Banshee, ed erano puntualmente morti.
 C’è un’atmosfera spiritosa e mai pesante. C’è ironia, sarcasmo, talora anche un accenno patetico, quando Sheringham viene a sapere di come la signora Plant per ricavare i soldi per il ricatto non avendoli, sia stata consigliata in sostanza dal ricattatore, di prostituirsi: lui le avrebbe presentato chi avrebbe ricompensato i suoi favori. In un periodo in cui la donna è ancora una vittima, e non un assassino. Del resto questo è il convincimento di Alec Grierson, il Watson di Sheringham, che laddove lui additi come possibile complice una donna, Grierson immediatamente la salva, non ammettendo che una povera innocente esponente del gentil sesso possa essere un’assassina.
C’è un’atmosfera spiritosa e mai pesante. C’è ironia, sarcasmo, talora anche un accenno patetico, quando Sheringham viene a sapere di come la signora Plant per ricavare i soldi per il ricatto non avendoli, sia stata consigliata in sostanza dal ricattatore, di prostituirsi: lui le avrebbe presentato chi avrebbe ricompensato i suoi favori. In un periodo in cui la donna è ancora una vittima, e non un assassino. Del resto questo è il convincimento di Alec Grierson, il Watson di Sheringham, che laddove lui additi come possibile complice una donna, Grierson immediatamente la salva, non ammettendo che una povera innocente esponente del gentil sesso possa essere un’assassina. Nella mia attività di critico a tempo perso e di blogger ho conosciuto parecchia gente: alcuni sono diventati amici, altri li ho persi strada facendo. Di questi, qualcuno l‘ho ritrovato ogni tanto, per es. Bernardo Cicchetti, Luca Conti, Giuseppina La Ciura; altri li ho irrimediabilmente persi. Però siccome il mondo è fatto a scale, se ne ho persi taluni, talaltri li ho acquistati. Mi è capitato, per es. di conoscere tempo fa, un ragazzo diciottenne che ha cominciato a seguirmi, soprattutto su Anobii, e poi anche sui miei blog, appassionato del mio stesso “pallino”, le Camere Chiuse, ma anche di tutto il genere poliziesco. Un ragazzo che sta aprendosi e quindi ha bisogno di una guida. Un bel giorno, parlando del più e del meno, gli ho rivelato una mia insoddisfazione: non aver potuto mai leggere un certo romanzo di Ngaio Marsh, il mio autore preferito, assieme a Carr ed Ellery Queen. Lui, in men che non si dica, più esperto del sottoscritto nel cercare articoli da comprare su internet, l’ha acquistato e poi me l’ha regalato. Io non ho potuto che ricambiare questo suo atto, regalandogli a mia volta sei romanzi che non possedeva.
Nella mia attività di critico a tempo perso e di blogger ho conosciuto parecchia gente: alcuni sono diventati amici, altri li ho persi strada facendo. Di questi, qualcuno l‘ho ritrovato ogni tanto, per es. Bernardo Cicchetti, Luca Conti, Giuseppina La Ciura; altri li ho irrimediabilmente persi. Però siccome il mondo è fatto a scale, se ne ho persi taluni, talaltri li ho acquistati. Mi è capitato, per es. di conoscere tempo fa, un ragazzo diciottenne che ha cominciato a seguirmi, soprattutto su Anobii, e poi anche sui miei blog, appassionato del mio stesso “pallino”, le Camere Chiuse, ma anche di tutto il genere poliziesco. Un ragazzo che sta aprendosi e quindi ha bisogno di una guida. Un bel giorno, parlando del più e del meno, gli ho rivelato una mia insoddisfazione: non aver potuto mai leggere un certo romanzo di Ngaio Marsh, il mio autore preferito, assieme a Carr ed Ellery Queen. Lui, in men che non si dica, più esperto del sottoscritto nel cercare articoli da comprare su internet, l’ha acquistato e poi me l’ha regalato. Io non ho potuto che ricambiare questo suo atto, regalandogli a mia volta sei romanzi che non possedeva.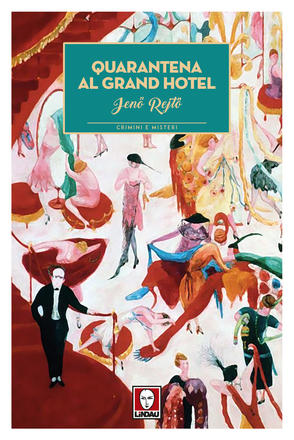 E’ passato un altro anno.
E’ passato un altro anno.

 Ma ancor più pazzesco appare il fatto quando la moglie di Itoi riceve una chiamata telefonica: alla stazione Asakusabashi della sopraelevata, vicino alla loro abitazione, hanno trovato il corpo di Kubo, sfracellato da un treno: pare che si sia suicidato, buttandosi sotto.
Ma ancor più pazzesco appare il fatto quando la moglie di Itoi riceve una chiamata telefonica: alla stazione Asakusabashi della sopraelevata, vicino alla loro abitazione, hanno trovato il corpo di Kubo, sfracellato da un treno: pare che si sia suicidato, buttandosi sotto. Shimada qui paga un pesante tributo mi sembra a tanti autori del passato.
Shimada qui paga un pesante tributo mi sembra a tanti autori del passato. Per me lo scorso 23 dicembre è stato un giorno importante, perché ho incontrato di nuovo un amico che ritenevo perso. Non sentivo Igor Longo da 9 anni. Non starò qui a dire le cause, e cosa gli sia capitato. Ne parlerò se lui vorrà un giorno, perché sarebbe anche una storia istruttiva in un certo senso. Fatto sta, che Igor nel frattempo, se già era a detta di Giulio Leoni “un’enciclopedia vivente” prima nel 2009, ora nel 2018, non saprei dire cosa sia diventato. Forse un computer vivente? Non so come faccia a leggere tanto, sia in italiano, ma soprattutto in inglese, francese e anche in spagnolo.
Per me lo scorso 23 dicembre è stato un giorno importante, perché ho incontrato di nuovo un amico che ritenevo perso. Non sentivo Igor Longo da 9 anni. Non starò qui a dire le cause, e cosa gli sia capitato. Ne parlerò se lui vorrà un giorno, perché sarebbe anche una storia istruttiva in un certo senso. Fatto sta, che Igor nel frattempo, se già era a detta di Giulio Leoni “un’enciclopedia vivente” prima nel 2009, ora nel 2018, non saprei dire cosa sia diventato. Forse un computer vivente? Non so come faccia a leggere tanto, sia in italiano, ma soprattutto in inglese, francese e anche in spagnolo.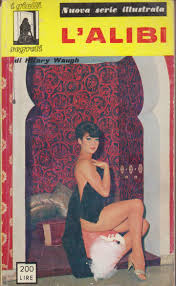
 La Canarina assassinata è uno dei più bei Gialli dell’Età d’Oro del romanzo poliziesco.
La Canarina assassinata è uno dei più bei Gialli dell’Età d’Oro del romanzo poliziesco. Un breve discorso a parte merita invece il passo:
Un breve discorso a parte merita invece il passo: Molto tempo fa parlammo di quella che è considerata unanimemente ancora, la miglior scrittrice statunitense di crime fiction, Helen McCloy. Ne parlammo, introducendo forse il suo romanzo maggiormente ammirato, cioè Through a Glass, Darkly. Helen McCloy a riguardo di quel romanzo buttò giù uno dei romanzi più emblematici sul delitto impossibile. Tuttavia esplorò anche altri generi. Oggi parliamo di una novella, un romanzo breve, presentato sull’ Ellery Queen Mystery Magazine dell’ Aprile 1953, Murder Is Everybody’s Business.
Molto tempo fa parlammo di quella che è considerata unanimemente ancora, la miglior scrittrice statunitense di crime fiction, Helen McCloy. Ne parlammo, introducendo forse il suo romanzo maggiormente ammirato, cioè Through a Glass, Darkly. Helen McCloy a riguardo di quel romanzo buttò giù uno dei romanzi più emblematici sul delitto impossibile. Tuttavia esplorò anche altri generi. Oggi parliamo di una novella, un romanzo breve, presentato sull’ Ellery Queen Mystery Magazine dell’ Aprile 1953, Murder Is Everybody’s Business.